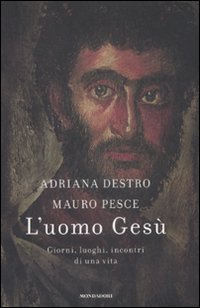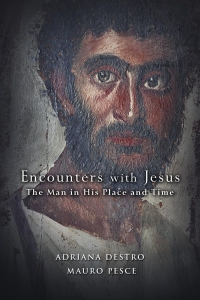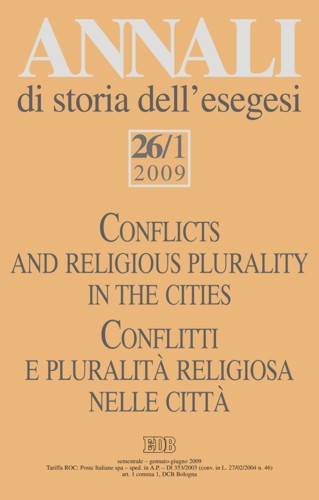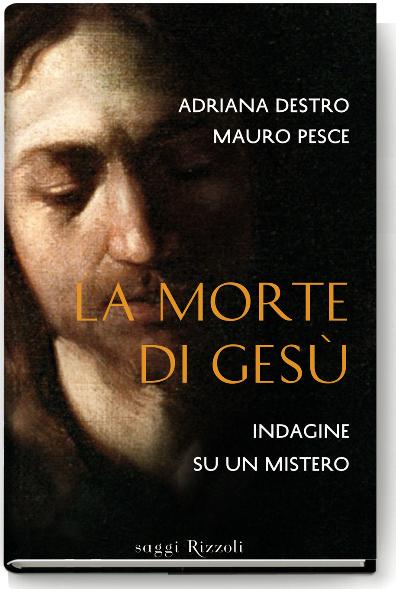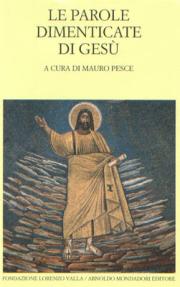Enrico Norelli su Repubblica
- Dettagli
- Categoria: articoli Inchiesta su Gesù
- Pubblicato Giovedì, 13 Settembre 2012 18:53
- Visite: 8140
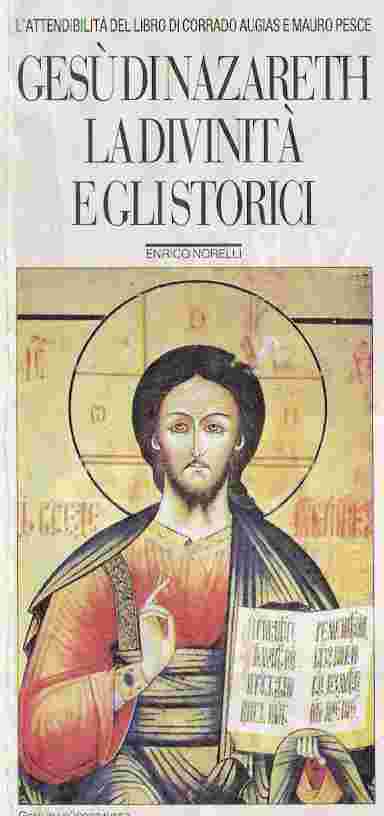
Enrico Norelli
Professore di Storia del cristianesimo delle origini all’università di Ginevra
Intervento sul libro Inchiesta su Gesù di Corrado Augias e Mauro Pesce
(vedi anche La Repubblica, 2 gennaio 2007, che riporta questo testo in forma abbreviata)
L’Inchiesta su Gesù di Corrado Augias e Mauro Pesce è una risposta seria alla necessità urgente di proporre i risultati delle complesse ricerche degli specialisti a un pubblico più largo, il quale dispone per lo più di trattazioni orientate da un’opzione di fede o di libri che promettono, più o meno esplicitamente, di aiutare lo sviluppo del senso critico rivelando “tutto quel che la chiesa ha sempre voluto nascondere” mentre s’ispirano al più avvilente dogmatismo.
Ho trovato questo libro, nel suo complesso, corretto, misurato, intelligente: un aiuto reale per chi, non essendo uno studioso delle origini cristiane, s’interroghi sulla figura storica di Gesù. Certo, contiene affermazioni che si possono discutere. Ma credo che le dure critiche che mi è avvenuto di leggere a suo riguardo non solo siano largamente ingiustificate nel merito, ma soprattutto contengano errori di metodo, che danneggiano, essi sì, il lettore non specialista.
Che cosa si può conoscere storicamente di Gesù? La conoscenza storica, qual è praticata oggi, ha le sue regole. Una di esse, che ci riguarda qui, è che non è lecito allo storico pronunziarsi sulla realtà di Dio e sulla sua azione nella storia. Chi fa storia metterà in luce le maniere in cui donne e uomini hanno sviluppato credenze religiose, caratterizzerà tali credenze, i loro presupposti, le loro trasformazioni e le conseguenze che hanno prodotto; spiegherà in che modo determinati gruppi hanno creduto che la divinità agisse nel mondo, e in quali maniere hanno creduto di mettersi in rapporto con essa. Ma non assumerà Dio come attore dei processi storici, perché l’esistenza di un Dio non lo riguarda, diversamente da quella di Alessandro il Grande o di Lenin. Da poeta cristiano, Alessandro Manzoni ha potuto chiedersi se e come Dio avesse agito in Napoleone; ma uno storico che volesse spiegare l’attività di Napoleone affermando che Dio si è servito di lui susciterebbe, a ragione, l’ilarità generale.
Il caso di Gesù di Nazaret non è diverso. Lo storico non si pronunzia sulla sua divinità, per la semplice ragione che si tratta di una questione estranea al suo campo e ai suoi mezzi d’indagine. E’ dunque letteralmente priva di senso l’obiezione, mossa al libro Inchiesta su Gesù dal P. Giuseppe De Rosa nel numero 3755 della Civiltà cattolica, di aver negato la divinità di Gesù. Se Pesce e Augias avessero negato la divinità di Gesù, avrebbe avuto ragione di protestare, ma non per la negazione, bensì perché se ne sarebbero occupati; avrebbe dovuto biasimarli allo stesso modo se l’avessero affermata. In realtà, a me pare che la questione della divinità resti completamente, e doverosamente, fuori dell’orizzonte del libro. Altra cosa è affermare che i credenti in Gesù hanno ammesso la sua divinità: ciò è di competenza dello storico, il quale peraltro può mostrare che non tutti i documenti cristiani più antichi lo hanno fatto.
Per la medesima ragione non condivido le considerazioni del P. Raniero Cantalamessa nell’Avvenire del 18 novembre, là dove, verso la fine del suo articolo consacrato al libro, afferma che fede e incredulità condizionano la ricerca storica allo stesso modo, anzi la seconda “enormemente di più”. Infatti, se per “fede” intende la disponibilità a spiegare mediante l’intervento di Dio dei fenomeni per i quali i nostri attuali paradigmi culturali non ci consentono spiegazioni, si tratta di un atteggiamento incompatibile con il metodo storico quale oggi è universalmente accettato. Se per “incredulità” intende la ricerca, per i medesimi fenomeni, di spiegazioni accettabili dai paradigmi delle “scienze umane” (nella consapevolezza che tali spiegazioni saranno superate un giorno dall’affermarsi di altri paradigmi), questo è un atteggiamento compatibile con il metodo storico. Tutto qui. Le due posizioni non possono essere rifiutate allo stesso modo.
Del resto, la foga polemica conduce talora Cantalamessa a presentare in maniera distorta il pensiero di Pesce. Nel contesto ora citato, afferma che, se ci si accosta a Cristo da non credente, “i miracoli [non potranno che essere] frutto di suggestione”. Ora Pesce afferma esattamente il contrario, basta leggere a p. 134: “io stesso mi sono convinto che è necessario ammettere l’esistenza di persone in grado di compiere autentiche guarigioni considerate ‘miracolose’, per le quali non esiste una spiegazione scientificamente verificabile. (...) La sua effettiva capacità taumaturgica (...) La sua capacità di fare miracoli (...)”. Anzi, Pesce cita anche episodi come le resurrezioni, il controllo delle forze della natura, la moltiplicazione del cibo, commentando: “sono convinto che questi episodi non siano stati inventati, ma che i suoi seguaci furono realmente convinti di avere assistito a quei fatti straordinari”. Senza ombra di dubbio, Pesce si rende conto che con affermazioni del genere si situa su di un terreno sul quale molti esegeti, tra cui anche dei cattolici, farebbero fatica a seguirlo. In generale, le persone competenti avrebbero il dovere, e il pubblico più ampio avrebbe il diritto, di sapere che – diversamente da quanto insinuano gli articoli che lo criticano – Pesce ha una fiducia nell’attendibilità dei racconti evangelici assai ampia rispetto alla media degli esegeti.
La foga polemica mi sembra anche trascinare il P. Cantalamessa a errori evidenti, come quando se la prende con “la tesi della totale estraneità delle autorità ebraiche alla morte di Cristo”, evidentemente dimenticando quanto Pesce afferma alle p. 160-161 sull’appoggio di una parte delle autorità di Gerusalemme alla condanna di Gesù. Non posso evitare di credere tale foga responsabile anche della furibonda tirata di Cantalamessa contro gli apocrifi, che si stenta a ricondurre a uno studioso competente come lui nel campo della letteratura cristiana antica. Come si può affermare che i critici più arditi “arrivano, con congetture, a datarli (= gli apocrifi) all’inizio del III o a metà del II secolo”, quando citazioni da parte di autori ben datati, o papiri databili paleograficamente, consentono di assegnare praticamente con certezza al II secolo una quantità di apocrifi, tra cui il Vangelo di Pietro, il cosiddetto Protovangelo di Giacomo, i vangeli degli Ebrei e degli Egiziani, il Vangelo di Tommaso (abbiamo frammenti di due copie degli inizi del III secolo), la Predicazione di Pietro, l’Apocalisse di Pietro, e altri, senza menzionare quelli che si possono attribuire con enorme probabilità al II secolo sulla base del loro contenuto, come l’Ascensione di Isaia? E come si può affermare che “i vangeli apocrifi professano tutti [sic!], chi più chi meno, una rottura violenta con l’Antico Testamento”, quando, per esempio, tra quelli ora menzionati, questo si può proporre tutt’al più, con molta incertezza, per il solo Vangelo di Tommaso, dove comunque tale tema non è minimamente esplicito? Non si dovrebbe accusare altri di distorcere i fatti storici e la valutazione delle fonti mentre si fa lo stesso, contribuendo a mantenere nei lettori un’immagine distorta degli apocrifi, dei quali negli ultimi decenni si è scoperta l’importanza fondamentale per conoscere la storia e il pensiero delle più antiche comunità cristiane.
Pesce, del resto, non privilegia gli apocrifi rispetto ai vangeli divenuti canonici; basta scorrere il libro per rendersi conto che si fonda incomparabilmente più sui secondi che sui primi, e inoltre afferma (p. 221) che il vangelo che ha meglio compreso Gesù è quello di Luca. Ciò che se mai desidera a giusto titolo mettere in evidenza è che bisogna prendere in considerazione tutti i vangeli anticamente in circolazione per poter comprendere come sono state trasmesse le parole di Gesù e i racconti su di lui, il che è necessario anche per capire come sono nati i vangeli poi canonizzati.
Credo che un punto cruciale, cui non a caso dedicano ampio spazio sia Cantalamessa che De Rosa, sia la questione dell’ebraicità di Gesù. Nessuno dei due la nega, né lo potrebbe, ma entrambi tengono a sottolineare la continuità tra Gesù ebreo e il cristianesimo; ora però, siccome “ebreo” non è “cristiano”, sono obbligati a mettere l’accento sulle novità dell’insegnamento di Gesù. Questo finisce con il condurre a delle acrobazie, soprattutto nel caso del P. De Rosa: “Gesù, sulla scia dell’antica Legge, proclama una Legge nuova, che non contraddice la prima, ma la compie”, per esempio con il comandamento dell’amore del nemico: ma se non c’è contraddizione, come si può dire che tali cose escono da ciò che è “integralmente ebraico”? “Compimento” equivale a “uscita”? (Muovendo lo stesso tipo di critica, De Rosa collega il “compimento” con la discontinuità, Cantalamessa con la continuità.) Il punto è che simili posizioni sono accettabili solo a partire dal presupposto che il giudaismo è inevitabilmente una religione formalista ed egoista, incapace di amare il nemico e di pregare per il persecutore, nonché di credere che l’amore di Dio è più forte dell’impurità; che interpretare i comandamenti in maniera radicale, estendendo per esempio all’insulto il divieto di uccidere, come avviene nelle “antitesi” citate al riguardo da Cantalamessa, è impossibile per un “ebreo”. Che Gesù interpreti spesso la Legge in maniera diversa da altri, tra cui possono esservi talora dei farisei, è chiaro; che questo significhi uscire dal giudaismo, lo è molto meno, e dietro un’idea del genere, malgrado ogni intenzione contraria, l’antigiudaismo è sempre in agguato. E se Cantalamessa, ironicamente, invita a chiedere agli ebrei cosa pensino di un Paolo “ebreo e non cristiano” (credo del resto che attualmente avrebbe delle sorprese), perché non invita a fare lo stesso anche per Gesù? Forse perché troppi, ormai, sono gli studiosi ebrei autorevoli che difendono l’ebraicità integrale di Gesù?
Molto altro sarebbe da dire, ma desidero terminare con una osservazione critica su di un punto della conclusione di Augias: la trovo in generale equilibrata, come ogni altro suo intervento nel libro, ma questo punto mi pare importante, e mi permette di riallacciarmi a quanto scrivevo all’inizio. Interrogandosi sull’enigma della grandezza di Gesù e della sua immensa influenza, Augias afferma (p. 241) che per un cristiano la spiegazione è semplice, viene dalla fede che Gesù è il Figlio di Dio, e “per qualunque cristiano il discorso può finire a questo punto”, mentre il non cristiano continuerà a porsi la domanda “è possibile parlare di Gesù e raccontarlo come un qualunque altro protagonista della storia, prescindendo cioè dalla sua ‘divinità’?”. Ebbene, io che cerco di essere cristiano non rinunzio affatto a quest’ultima domanda. Proprio quella che è divenuta l’ortodossia cristiana ha sempre affermato l’umanità di Gesù e, se è così, il credente non può rinunziare a cercar di capire Gesù come essere umano, sul piano storico. Al contrario: è vero che la ricerca storica non potrà mai “dimostrare” la divinità di Gesù (non lo potrebbe neanche se, per ipotesi che ritengo assurda, giungesse a concludere che tutto quanto gli attribuiscono i vangeli ha avuto luogo letteralmente, perché comunque non potrebbe logicamente dedurne la divinità, tale passaggio essendole per definizione estraneo); ma per lasciar afferrare la propria vita dalla forza di Gesù, per avere “fede” in lui, è necessario incontrare quest’uomo vissuto in terra d’Israele quasi duemila anni fa. Stranamente, e certo contro le intenzioni di Augias, questo suo enunciato lascerebbe pensare che l’approccio di questo libro è, secondo lui, tipico del non credente, mentre tipico del credente sarebbe quello della fede. Su tale opposizione non posso seguirlo, e sono convinto che i cristiani, non meno degli altri, hanno un gran bisogno di un libro come questo e dovrebbero esserne grati a lui e al professor Mauro Pesce.